Le politiche attive del lavoro: trent’anni di evoluzione tra visione, risultati e nuove sfide
Dalla Legge 196/1997 alla transizione digitale: come cambia il modo di creare opportunità occupazionali
A quasi trent’anni dalla Legge 196 del 1997, che introdusse un impianto organico di politiche attive nel nostro Paese, il dibattito sull’efficacia e sulla funzione di questi strumenti torna al centro delle agende istituzionali e territoriali.
Fu proprio con quella legge — nata in un contesto di profonda ristrutturazione del mercato del lavoro — che si sancì un principio destinato a trasformare l’approccio pubblico all’occupazione: passare da un modello assistenziale a uno di attivazione, in cui la persona disoccupata diventa protagonista del proprio percorso, e i servizi pubblici e privati assumono il ruolo di facilitatori dell’incontro tra domanda e offerta.
Quel passaggio culturale ha aperto una stagione che, nel corso di tre decenni, ha visto evolvere strumenti, linguaggi e attori: dai tirocini formativi alle doti lavoro, dai programmi di ricollocazione fino ai recenti dispositivi del Programma GOL e delle missioni PNRR, oggi orientati alla digitalizzazione e alla personalizzazione dei percorsi.
Le politiche attive si sono così trasformate da iniziative sperimentali a leva sistemica di sviluppo, capaci di integrare formazione, orientamento e servizi al lavoro in un ecosistema unico.
L’Italia del lavoro: trend e segnali recenti
Dopo la crisi pandemica, il mercato del lavoro italiano ha mostrato segnali di tenuta e crescita.
Secondo ISTAT, nel 2024 il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni ha raggiunto il 61,5 %, il valore più alto mai registrato dal 1977, con un incremento di 2,4 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Nel primo trimestre del 2025, la crescita degli occupati è stata pari a +0,6 % sul trimestre precedente e +1,8 % su base annua, grazie soprattutto alla spinta dei contratti a tempo indeterminato (+4 %).
Il tasso di disoccupazione è sceso al 6,8 %, con una riduzione di oltre 200 mila persone in cerca di lavoro rispetto all’anno precedente.
Tuttavia, nel confronto con l’Unione Europea, l’Italia resta sotto la media occupazionale (70,4 % nella fascia 15–64 anni): un divario che evidenzia quanto la qualità dei servizi per l’impiego e la capacità di matching siano determinanti.
Il nodo non è più soltanto “creare posti di lavoro”, ma facilitare connessioni efficaci tra le competenze disponibili e i fabbisogni reali delle imprese, in un contesto in cui la transizione digitale e verde ridefinisce le professioni stesse.
Politiche attive: obiettivi e architettura del sistema
Le politiche attive del lavoro — come definite dal Ministero del Lavoro e da ANPAL — comprendono oggi un insieme articolato di strumenti e servizi che mirano all’inserimento o reinserimento occupazionale attraverso percorsi personalizzati.
Sono azioni di sistema che uniscono orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro, incentivi e supporto alla mobilità professionale, spesso in stretta connessione con i fondi interprofessionali, le regioni e le agenzie per il lavoro.
Dai tempi della Legge 196/97, l’idea di fondo è rimasta invariata: favorire la partecipazione attiva delle persone e la responsabilità condivisa dei territori.
Ma ciò che nel tempo è cambiato è la natura della competenza necessaria per rendere efficace questo sistema: oggi l’intermediazione non è solo burocratica, ma strategica; richiede analisi, negoziazione, sensibilità economica e capacità di lettura delle dinamiche aziendali.
Dati, modelli e punti critici
I rapporti più recenti dell’Osservatorio sul mercato del lavoro evidenziano come le politiche attive siano ormai parte integrante della competitività territoriale.
Nel 2024, oltre 850 mila persone hanno partecipato a percorsi di ricollocazione o formazione attiva, e quasi il 60 % dei partecipanti ha trovato una nuova occupazione entro sei mesi dal completamento. Tuttavia, permangono forti differenze regionali: il tasso di inserimento supera il 70 % nel Nord, ma scende sotto il 40 % nel Mezzogiorno.
Tre le criticità più ricorrenti:
-
La frammentazione dei sistemi regionali e la difficoltà di integrare le piattaforme digitali di tracciamento.
-
Il disallineamento tra i fabbisogni delle imprese e le competenze dei candidati, soprattutto nei settori STEM, digital e green.
-
La misurazione dell’efficacia: ancora oggi, solo una parte dei servizi riesce a correlare gli esiti occupazionali con i percorsi formativi seguiti.
Nonostante ciò, i trend più recenti mostrano che dove esiste un coordinamento stabile tra pubblico e privato — e dove le agenzie e i centri per l’impiego riescono a instaurare un dialogo costante con il tessuto produttivo — i risultati migliorano in modo significativo.
Un equilibrio complesso ma generativo
A ben guardare, le politiche attive funzionano come un sistema vivente: interdipendente, adattivo, capace di rinnovarsi solo se i suoi attori evolvono con esso.
Le norme definiscono la cornice, le risorse ne garantiscono la sostenibilità, ma il vero motore è l’interazione quotidiana tra chi legge i bisogni delle imprese e chi accompagna le persone nel tradurli in obiettivi professionali.
È in questo spazio — quello della relazione — che le politiche attive producono il loro valore più alto: non semplicemente collocare, ma connettere; non solo attivare, ma orientare con visione e responsabilità.
Laddove questa capacità di intermediazione si consolida, si assiste a una crescita qualitativa dell’occupazione, a una maggiore stabilità dei rapporti di lavoro e a una fiducia rinnovata nel ruolo dei servizi come strumenti di sviluppo e non di emergenza.
Guardare avanti: intelligenza artificiale, reti e capitale umano
Le sfide del prossimo decennio impongono una rilettura profonda del sistema.
La diffusione dell’intelligenza artificiale nei processi di selezione, orientamento e formazione introduce nuove opportunità ma anche responsabilità: la tracciabilità dei dati, la trasparenza degli algoritmi e la qualità delle interazioni umane resteranno fattori decisivi.
In parallelo, la creazione di reti territoriali pubblico-private e l’integrazione tra dati amministrativi e competenze digitali aprono la strada a una nuova generazione di politiche attive basate sull’evidenza, non più sull’intuizione.
Ma alla base di tutto rimane la stessa sfida di trent’anni fa: trasformare le persone da beneficiari in protagonisti del cambiamento, restituendo loro strumenti, fiducia e direzione.
Solo così le politiche attive continueranno a essere ciò che il legislatore aveva immaginato nel 1997: una leva per liberare il potenziale delle persone e sostenere la competitività dei territori.


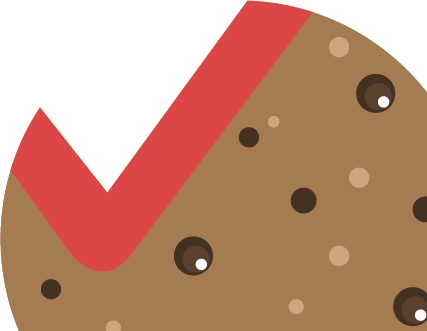
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.